di Fiona Diwan
Coppia, amore, rispetto, eros, attrazione, contratto, patto di lealtà, tentazioni e tradimento… Ma anche il rapporto con i figli e il principio della trasmissione matrilineare che fonda l’identità ebraica. Incentrato sul tema del matrimonio e della sua regolamentazione giuridica, esce in traduzione italiana (Giuntina) Qiddushin (Matrimonio), uno dei più importanti trattati del Talmud Babilonese, a cura di Rav Riccardo Di Segni
L’uomo che non ha una moglie vive senza gioia, senza benedizione, senza Bene, diceva Rabbi Tanchum a nome di Rabbi Chanilai in Talmud Jevamoth. A commento ulteriore, rincara la dose Ravà: colui che ami la propria moglie come se stesso e la rispetti più di se stesso “conoscerà la pace che è nella sua tenda, visiterà la sua dimora e la troverà integra”, e soprattutto condurrà i propri figli su una via diritta affinché si sposino nel tempo giusto. “Procurati di che vivere con la donna che ami”, chiosa ancora Qiddushin, trattato talmudico interamente dedicato alla legislazione in fatto di sponsali e nozze. Meglio in due che da soli, quindi. Non è bene che l’Uomo rimanga solo. Ma come regolare e ordinare giuridicamente l’istituzione del matrimonio? Il problema se lo pose, nella notte dei tempi, il popolo ebraico. Senza dimenticare che, vecchia di 35 secoli, la legislazione ebraica in merito sorge e si colloca in un contesto sociale, in una temperie storica, fatti di rapporti di forza e di abuso tra uomo e donna, in un tempo rapace, maltrattante e barbarico nei confronti delle donne, introducendo un principio regolatore e di equità nelle unioni tra maschio e femmina. Si inizia così a codificare l’istituto del matrimonio ebraico. Certo, “ratti delle Sabine” ce n’erano stati a gogò, e ben prima di Roma, vedi la sorte toccata a Dina figlia di Yaakov, rapita dagli abitanti di Shechem, tempi in cui le donne venivano semplicemente “requisite” senza tante cerimonie dal più protervo e potente di turno o, nel migliore dei casi, “comperate”, acquistate dietro somma di denaro data al padre. Solo col tempo, l’istituto della dote ha invertito l’uso, per cui non sarà più il maschio a dover fornire una somma o portare un corrispettivo per avere una moglie ma sarà invece la femmina a dover fornire una dote, dote che sarebbe rimasta di sua proprietà e, in caso di divorzio, restituita in forma di salvaguardia economica.
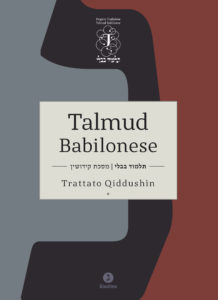 Incentrato sul tema del matrimonio ebraico e sulla sua regolamentazione giuridica, esce oggi in traduzione italiana per l’editore Giuntina, in libreria dal 7 novembre, il doppio volume del trattato talmudico di Qiddushin (Matrimonio), curato da Rav Riccardo Di Segni, la terza uscita dell’opera monstre che prevede, anno dopo anno, la traduzione dell’intero corpus talmudico babilonese (prossime uscite nel 2020 i trattati di Betzà, Meghillà, Chaghigà – quest’ultimo è stupefacente per le implicazioni circa la mistica ebraica e il concetto di Merkavà-), realizzata nel quadro del protocollo siglato nel 2011 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIUR, CNR e Unione Comunità Ebraiche Italiane – Collegio Rabbinico Italiano.
Incentrato sul tema del matrimonio ebraico e sulla sua regolamentazione giuridica, esce oggi in traduzione italiana per l’editore Giuntina, in libreria dal 7 novembre, il doppio volume del trattato talmudico di Qiddushin (Matrimonio), curato da Rav Riccardo Di Segni, la terza uscita dell’opera monstre che prevede, anno dopo anno, la traduzione dell’intero corpus talmudico babilonese (prossime uscite nel 2020 i trattati di Betzà, Meghillà, Chaghigà – quest’ultimo è stupefacente per le implicazioni circa la mistica ebraica e il concetto di Merkavà-), realizzata nel quadro del protocollo siglato nel 2011 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIUR, CNR e Unione Comunità Ebraiche Italiane – Collegio Rabbinico Italiano.
Il Talmud è un’opera totale, l’opus magnum dell’ebraismo, la Torà SheBe’alpè come è noto, e ogni trattato ne riflette la vocazione omni-compensiva e omni-includente: in Qiddushim si parla infatti non solo di matrimoni in numerose varianti (matrimonio con minori, principio della consensualità della donna, abusi…), ma anche di rapporti tra genitori e figli, di corretta igiene relazionale non solo tra uomo e donna ma anche tra schiavo e padrone… È in Qiddushin che si codificano alcune leggi fondanti dell’ebraismo post rabbinico. «Il trattato di Qiddushin è estremamente attuale, è alla base di uno dei temi più caldi del momento: il principio di matrilinearità ovvero dell’ebraismo trasmesso per linea materna», ci spiega Rav Riccardo Di Segni, Rabbino capo di Roma, direttore del Progetto Talmud, incontrato a Milano. «Seguendo il diagramma di flusso con cui il tema viene argomentato, giungiamo a capire come i Maestri siano arrivati a sancire il principio di matrilinearità e perché, quali le eccezioni o le altre regole a latere, che cosa accade nei casi dei matrimoni tra un Coen e una Levì ad esempio, oppure tra una donna Coen e un uomo Israel, o ancora in caso di matrimonio misto, e quand’è che una unione può dirsi legittima e quando non lo è… Il concetto di base è che l’identità della persona, e quindi anche l’identità ebraica, si definisce a partire dai genitori. Proprio in Qiddushin troviamo l’intera discussione, nonché i brani che inquadrano e organizzano questa complessa materia. Sono regole complicate? Certamente. Ma la complicatezza, la complessità, non fanno forse parte dell’identità ebraica? Esistono forse legislazioni non complicate?», dice Di Segni.
Il Talmud dedica quasi un intero Ordine, Nashìm, e ben cinque trattati al diritto matrimoniale: Yevamòt del levirato; Ketubbòt si occupa delle scritture matrimoniali e dei doveri coniugali; Sotà dell’infedeltà coniugale; Ghittìn dei divorzi e Qiddushìn delle modalità di stabilimento del vincolo coniugale. Nella sequenza dei trattati Qiddushìn viene dopo Ghittìn, e non al contrario come dovrebbe essere nell’ordine temporale e logico, forse perché quell’ordine potrebbe sembrare di cattivo augurio: quindi meglio prima trattare i divorzi e poi i matrimoni. Spiega Rav Di Segni nell’Introduzione dei due volumi: «Il termine qiddushìn, che dà il nome a questo trattato, significa letteralmente “consacrazioni”. Al plurale qiddushìn è riferito solo al vincolo nuziale ed è un termine di uso rabbinico, assente nella Bibbia. I rabbini introdussero e fecero prevalere il termine qiddushìn per sottolineare l’aspetto sacrale del vincolo rispetto a quello puramente giuridico, l’uomo “dà i qiddushìn” nel senso che l’uomo lega a sé la donna e la donna li riceve, nel senso che accetta il legame con atto volontario; la donna che li ha ricevuti è detta mequddèshet o meorasà. Tradurre questi termini in italiano è problematico perché i concetti di “fidanzamento”, “matrimonio”, “nozze” non corrispondono esattamente alle strutture giuridiche del matrimonio secondo le regole rabbiniche. Queste infatti prevedono un processo in due tempi: il primo, dei qiddushìn o erusìm in cui l’uomo lega o consacra a sé una donna, e da quel momento scatta il divieto di adulterio, ma la coabitazione ancora non è consentita; quindi è una situazione più impegnativa del “fidanzamento”, ma ancora non è un matrimonio completo; il secondo tempo, detto nissuìm, dalla radice nun-sin-àlef, che indica il portare, una sorta di deductio ad domum degli antichi romani, in cui la sposa veniva portata a casa del marito, che sanciva l’inizio della vita coniugale. Ai tempi del Talmud tra la prima e seconda procedura potevano passare mesi o anni; da qualche secolo le due procedure sono in sequenza immediata e questo rappresenta una delle evoluzioni delle forme del matrimonio ebraico».
Perché l’atto sia valido e riconosciuto non è sufficiente il semplice “acquisto”, ma è necessaria una procedura formalmente corretta, che prevede l’assenso libero e consapevole delle parti (già documentato per la matriarca Rivqà, in Genesi 24:57), la presenza di testimoni (indispensabili) e la compatibilità dei coniugi, non essendo valida la procedura con una donna già sposata, o legata all’uomo da certi vincoli parentali o nel caso in cui uno dei coniugi non sia libero. La forma legale è simile a quella dell’acquisto, e questo consente una serie di confronti e analogie con altri tipi di acquisti ma fa anche emergere differenze sostanziali. Perché si tratta sempre di un acquisto sui generis, del tutto particolare. In un normale acquisto c’è un acquirente, un venditore e un bene che passa passivamente di proprietà; in questo caso il venditore e il bene si identificano, la questione non si esaurisce in un semplice dare-avere. Il concetto di acquisto è necessario per definire la struttura giuridica dell’atto, è un tema di uso nelle discussioni di questo trattato, ma è solo una parte di un legame più complesso in cui è indispensabile il consenso, la progettualità comune, l’armonia, la crescita spirituale (non estranea a questo la definizione di qiddushìn, data dai Maestri come atto di consacrazione). In questo trattato non si parla quasi mai di amore coniugale e il sesso è perlopiù visto come una tentazione da controllare, ma è evidente che la dimensione strettamente giuridica non può escludere gli altri aspetti del legame coniugale. Proprio questo trattato che si apre con un’immagine di “donna-oggetto”, che viene acquistata, è quello che stabilisce il principio fondamentale della matrilinearità dell’appartenenza all’ebraismo, dando alla parte femminile il ruolo fondamentale di trasmissione».
I qiddushìn inoltre rappresentano lo strumento fondamentale per regolare l’esercizio della sessualità nella società; il rapporto sessuale libero e casuale al di fuori del matrimonio è criticato e considerato zenùt, fornicazione, e la legittimità di un rapporto stabile con una donna non sposata (pilèghesh, concubina, di cui si parla nella Bibbia) è messa in discussione tra i Maestri; e anche chi è disposto a tollerare l’istituto del “concubinaggio” sottolinea che la differenza sta nello stato della donna, che senza i qiddushìn non è tutelata legalmente. Oggi, chi assiste a un matrimonio ebraico, a confronto con le discussioni che riempiono le pagine di questo trattato, troverà molte differenze: la contestualità e successione immediata dei qiddushìn e dei nissuim, di cui si è detto; l’acquisto/consacrazione fatto non con una somma di danaro ma con un anello di valore minimo (l’anello non è mai citato in questo trattato talmudico); l’età della sposa, oggi ben superiore ai minimi accettati in questo trattato (nelle decisioni del 1950 del rabbinato centrale dello Stato d’Israele, ad esempio, l’età della sposa non deve essere inferiore a 16 anni); il divieto di poligamia, divenuto effettivo nel mondo ashkenazita dall’anno Mille e di qui progressivamente estesosi in tutto il mondo ebraico. Rispetto a queste differenze ormai consolidate, la discussione di questo trattato “fotografa” lo stato della legge ebraica nella prima metà del primo millennio dell’era volgare.
Sempre parlando di realtà problematiche ve ne sono altre due che Qiddushìn vengono esaminate e confrontate: la schiavitù dei non-ebrei e il matrimonio delle minorenni. Il primo di questi istituti era lecito in epoca talmudica ed è stato codificato nei secoli successivi. Per quanto l’idea stessa di schiavitù sia comunque inaccettabile ai giorni nostri, va precisato che la regolamentazione ebraica, a partire dalla Bibbia, era ben diversa dalle leggi in vigore in altri sistemi; basta pensare alla tutela dell’integrità fisica: in seguito a un danno permanente – era sufficiente la perdita di un dente – lo schiavo acquistava la libertà, non solo, diventava ebreo libero in quanto il suo ingresso, seppure come schiavo, nella società ebraica, comportava un procedimento, anche formale, di ebraicizzazione a tutti gli effetti. Questo spiega anche perché molti sistemi giuridici, a cominciare dalle norme emanate dall’imperatore Giustiniano, proibirono agli ebrei di avere schiavi, per la preoccupazione che questo potesse diventare un modo di giudaizzare pagani e cristiani.
Il matrimonio delle minorenni (sotto i 12 anni e mezzo) consisteva nella possibilità per il padre di dare la figlia in sposa a qualcuno, incassando egli stesso la somma dei qiddushìn, per quanto minima. Solo il padre aveva questa facoltà; se la minorenne era orfana di padre la facoltà passava ai fratelli maggiori, ma essendo questa estensione di facoltà una norma rabbinica, che anticamente veniva intesa come una tutela della ragazza, venne riconosciuto alla ragazza il diritto al miùn, il rifiuto, al compimento dei dodici anni, che annullava il legame, senza necessità di divorzio. Questo trattato talmudico affronta il problema e ne discute le modalità. Chi ha studiato la questione dal punto di vista storico, esaminando le fonti, in particolare di questo trattato, è arrivato alla conclusione che i qiddushìn delle minorenni fossero praticati in epoca tannaitica, ma dopo divennero oggetto di critica progressiva specialmente nell’area babilonese. Rav, un amorà babilonese della prima generazione, diceva che è proibito far dare i qiddushìn alla figlia fino a quando questa diventi grande e dica: “Voglio questa persona” (p. 41a). D’altra parte emerge che i qiddushìn delle ragazze erano comunque precoci, avvenendo di norma subito dopo la pubertà. L’età consigliata per il matrimonio per i maschi era 18 anni. «Nel corso della storia successiva l’applicazione dell’istituto fu influenzata da circostanze sociali e differenti sensibilità. Povertà e incertezza politica spingevano al matrimonio precoce che poteva rappresentare una garanzia di sicurezza per il futuro delle bambine e delle famiglie. La proibizione di Rav fu recepita nella regola sefardita (Shulchàn Arùkh, Èven ha‘Èzer 37:8) mentre fu accettata con riserve da parte del mondo ashkenazita, che la tollerava “perché noi siamo nella diaspora e non sempre abbiamo la possibilità di fornire una dote, e anche perché siamo pochi e non sempre si trova un accoppiamento idoneo” (Remà, ibid.). Si noti come l’ebraismo ashkenazita che tollerava questa forma di matrimonio era proprio lo stesso ebraismo che aveva proibito per primo la poligamia», scrive Rav Di Segni nell’Introduzione.
Il quarto e ultimo capitolo di questo trattato prosegue con un’ampia digressione sulle diverse categorie in cui è classificabile il popolo ebraico. Speciale attenzione è dedicata ai kohanìm, che per i divieti loro imposti nelle scelte matrimoniali devono fare accertamenti genealogici accurati. L’argomento che chiude il trattato è il divieto di appartarsi con persone dell’altro sesso e l’indicazione di evitare situazioni di promiscuità. La narrazione passa quindi al racconto di casi di tentazioni alle quali furono esposti rabbini illustri. Dalla classificazione dei mestieri a rischio di promiscuità si passa al tema più generale del mestiere da scegliere, che sia onesto, dignitoso e poco faticoso, e questo offre lo spunto per la chiusura solenne del trattato con una lode per lo studio della Torà, indicato come la migliore attività a cui l’uomo possa dedicarsi. Perché ammalarsi di troppo lavoro, fatica e stress era per i Maestri della tradizione ebraica altamente negativo e altrettanto alienante che per Karl Marx o per i moderni sociologi di oggi. Il lavoro totalizzante, con il conseguente burnout, è da evitarsi come la peste, scrivevano. In definitiva, sono lo studio e la lettura a costituire la miglior profilassi per un’igiene dell’anima e del corpo, per un’igiene spirituale e persino…matrimoniale!



