di Ilaria Ester Ramazzotti
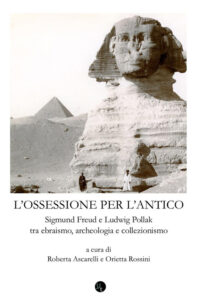 Uno sguardo psicanalitico lanciato sulla scrittura di Franz Kafka, alla ricerca della sua ebraicità. L’occasione è data da un approfondimento di David Meghnagi contenuto nel saggio Freud, la Bildung e il motto di spirito più riuscito (pubblicato quest’anno in A.A.V.V., L’Ossessione per l’Antico, Sigmund Freud e Ludwig Pollak tra ebraismo, archeologia e collezionismo, Atti del Convegno: Roma, Palazzo Braschi, 7.4.2019 a cura di Roberta Ascarelli e Orietta Rossini, Copyright Fondazione Museo Ebraico di Roma, Edizioni עt). Un approfondimento che getta luce sull’esistenzialismo, sullo stile letterario e di vita dello scrittore boemo di lingua tedesca nato a Praga nel 1883, cresciuto in una famiglia ebraica. Ne riportiamo di seguito alcuni spunti.
Uno sguardo psicanalitico lanciato sulla scrittura di Franz Kafka, alla ricerca della sua ebraicità. L’occasione è data da un approfondimento di David Meghnagi contenuto nel saggio Freud, la Bildung e il motto di spirito più riuscito (pubblicato quest’anno in A.A.V.V., L’Ossessione per l’Antico, Sigmund Freud e Ludwig Pollak tra ebraismo, archeologia e collezionismo, Atti del Convegno: Roma, Palazzo Braschi, 7.4.2019 a cura di Roberta Ascarelli e Orietta Rossini, Copyright Fondazione Museo Ebraico di Roma, Edizioni עt). Un approfondimento che getta luce sull’esistenzialismo, sullo stile letterario e di vita dello scrittore boemo di lingua tedesca nato a Praga nel 1883, cresciuto in una famiglia ebraica. Ne riportiamo di seguito alcuni spunti.
Il contesto storico è quello dell’uscita dai ghetti e dell’emancipazione, che nell’Impero Austro-Ungarico risale al 1867. Un periodo in cui alla conquistata libertà e alla cittadinanza ottenuta si accompagnano la spinta all’inclusione e all’assimilazione nella società e spesso la necessità di rideterminare la propria identità ebraica. “È interessante, a tale riguardo, mettere a confronto le soluzioni che Freud e Kafka danno a un problema che è insieme storico ed esistenziale – scrive David Meghnagi -. Tanto Freud che Kafka appaiono consapevoli che la loro scrittura è un luogo di sublimazione delle ansie di un’intera generazione. Entrambi aspirano all’universale. Nel caso di Freud mediante una proposta teorica e scientifica. Nel caso di Kafka con il ricorso a una scrittura criptica e gnostica”.
L’opera e i personaggi di Kafka sono alimentati da senso di alienazione, angoscia esistenziale, crisi psicologica e introspezione, conflitti generazionali. Esemplare in questo senso è il racconto La Metamorfosi, in cui il protagonista Gregor Samsa si risveglia una mattina trasformato in un enorme insetto. Da scrittore allegorico, secondo alcuni critici letterari, l’autore rappresenta ogni vicenda per dire altro: il senso di colpa, l’impotenza umana del singolo di fronte al mondo e alla sua burocrazia, per esempio, ma anche la solitudine e la diversità dell’ebreo nella Mitteleuropa, nonché l’estraneità dalla sua famiglia. Se per James Hawes non traspare nelle righe di Kafka alcun riferimento ebraico, per i critici Harold Bloom e Lothar Kahn Kafka è invece uno scrittore ebreo per eccellenza. Sulla stessa linea, Pavel Eisner, uno dei suoi primi traduttori, interpreta il romanzo Il Processo come allegoria della dimensione dell’esistenza ebraica di Praga: il protagonista Josef K. è simbolicamente arrestato da un tedesco, da un ceco e da un ebreo.
“In Kafka, scrittura e ebraismo vengono a coincidere – sottolinea a riguardo David Meghnagi –. La perdita delle radici, anche erranti, assurge a dolorosa erranza della scrittura. Parafrasando Primo Levi, in tale erranza è possibile cogliere il grido di chi cresce senza patria e certezza dell’avvenire, con la memoria rinnovata del dolore di un esilio senza fine”. Inoltre, “quel che Freud cerca di spiegare con riferimento a strutture universali operanti in ogni uomo di ogni luogo, compare in Kafka come il problema di ogni uomo in situazioni limite. Il tema della nudità […] trova il suo riscontro nel Processo di Kafka nella condizione del Sig. K., che non ha nemmeno un nome cui riferirsi di fronte a un potere divenuto del tutto estraneo e incomprensibile”.
Seppur avesse un rapporto controverso con l’ebraismo, l’autore boemo era profondamente affascinato dalla spiritualità che vedeva negli ebrei dell’Europa orientale. Il suo diario è pieno di riferimenti a scrittori yiddish. “Kafka elimina dai suoi celebri racconti ogni riferimento diretto alla propria vicenda personale, relegando invece ai diari e all’epistolario, veri gioielli di letteratura, la chiarificazione del senso nascosto di una scrittura dolorante, in cui l’elemento ebraico era un asse portante”, spiega ancora Meghnagi nel suo saggio. “Andando al cuore di un paradosso, Kafka sottolinea il dramma della maggior parte di coloro che hanno cominciato a scrivere in tedesco, la condizione di sospensione in cui vivevano, il rifiuto di cui sono oggetto nella società tedesca, la contraddittorietà delle loro identificazioni. Rivoltante è per Kafka la mancanza di chiarezza, l’ambiguità e la contraddittorietà che i genitori hanno trasmesso ai figli, essere e non essere, volere e non volere allo stesso tempo. Non avendo sciolto il suo nodo edipico, Kafka resta al di qua di una lettura comprensiva del dramma dei padri ed è impietoso nei loro confronti”. Così, “non potendo rivolgere direttamente il suo amore ferito verso il padre, Kafka lo sposta verso un’immagine più antica delle origini, comportandosi un po’ come i figli che non sentendosi capiti dai padri si rivolgono ai nonni. Idealizzando l’ebraismo orientale in cui vede un ebraismo più genuino”.
“Il ‘complesso del padre’, di cui la psicoanalisi si fa veicolo universalizzandolo, resta sostanzialmente per Kafka il problema del rapporto del figlio ebreo emancipato con il padre ebreo, di un’appartenenza talora rifiutata ma mai realmente superata, e dell’accusa di doppia appartenenza, di cui gli ebrei usciti dai ghetti sono fatti oggetto, anche quando hanno rotto definitivamente i ponti con le loro origini”, evidenzia il professore. “Raccogliendo implicitamente la sfida posta da Kafka, di cui non poteva conoscere le riflessioni segrete, con Freud il problema dell’’ebraismo del padre’, che ossessiona larghi settori dell’ebraismo occidentale, si trasformava nel problema generale del rapporto di ogni figlio con il ‘padre’ e la ‘legge’”. Di nuovo, nella prospettiva freudiana, anche il nodo delle radici esistenziali diventa generale e universale.
Immerso nell’accavallarsi di vicende personali e generazionali, verso la fine della sua vita Kafka esprimeva l’idea di emigrare in Terra d’Israele. Infatti, lo scrittore “non rinuncia alla sua identità, né intende partecipare all’autoflagellazione in cui precipitano non pochi ebrei sospesi tra un mondo ormai abbandonato (o rifiutato) e un mondo che spietatamente li esclude. E se anche la speranza di ricostruire un’esistenza spezzata nella Terra dei padri, studiando l’ebraico, appare come atto di resilienza estrema contro la malattia, non per questo appare meno importante e significativa”.
“Il fatto di scrivere in tedesco è per Kafka un aspetto di superficie – specifica David Meghnagi in un altro passo del suo testo -, almeno questa è la percezione con cui il mondo tedesco guarda con crescente malessere alla grande esplosione di creatività ebraica seguita all’uscita degli ebrei dai ghetti. La conseguente disperazione è per Kafka la fonte della loro ispirazione”. Ma “la disperazione, aggiunge Kafka penetrando a fondo il problema, non è ‘una cosa che si potesse placare scrivendo’ in quanto era ‘nemica della vita e dello scrivere’. Lo scrivere in tali condizioni era ‘soltanto una cosa provvisoria, come per chi scrive il proprio testamento un istante prima di impiccarsi’, una cosa provvisoria che poteva però ‘benissimo durare una vita intera’”. Una provvisorietà esistenziale colta e narrata fra esilio e emancipazione, fra privato e universale.



