di Fiona Diwan
Letteratura; un saggio di Luca De Angelis.
Un affresco dell’ebraismo letterario del Novecento: Kafka e Primo Levi, Malamud, Italo Svevo e Romain Gary… Da sempre la pratica letteraria rappresenta la via regia dell’autocoscienza ebraica, il luogo dove rintracciare in alta definizione l’anima della modernità. Come mai il XX secolo ha prodotto un numero così strabiliante di capolavori? In un saggio di Luca De Angelis la risposta: perché l’ebreo è da sempre “il caso estremo dell’uomo”
 «Ero talmente occupato a mettere ordine sulla terra che lasciai raffreddare il caffè». La battuta è tratta da un racconto di Isaac B. Singer, ed è come se fosse la voce del Padreterno in persona a parlarci, a evocare quella sacralità domestica, quell’intimità con il divino che da sempre caratterizza l’esperienza ebraica. «Per credere in Dio bisogna avere senso dell’umorismo», sosteneva lo scrittore Bernard Malamud. «TU governi e io sto all’opposizione», rincarava Woody Allen, “una leale opposizione, sia chiaro”, specificava Allen.
«Ero talmente occupato a mettere ordine sulla terra che lasciai raffreddare il caffè». La battuta è tratta da un racconto di Isaac B. Singer, ed è come se fosse la voce del Padreterno in persona a parlarci, a evocare quella sacralità domestica, quell’intimità con il divino che da sempre caratterizza l’esperienza ebraica. «Per credere in Dio bisogna avere senso dell’umorismo», sosteneva lo scrittore Bernard Malamud. «TU governi e io sto all’opposizione», rincarava Woody Allen, “una leale opposizione, sia chiaro”, specificava Allen.
Un irriverente “diritto di questionare” con Dio, di tirarlo per la giacchetta e di apostrofarlo, il levare all’Eterno la voce per protestare contro le ingiustizie nel mondo, in nome dell’Uomo, perorando la sua causa: perché il Giusto soffre mentre il malvagio trionfa? Fino a quando dureranno le tenebre d’Egitto? Fino a quando dovremo vivere scappando?, si chiede l’ebreo in ogni tempo. D’altronde, anche per Kafka non si poteva parlare di Dio, si poteva solamente parlare a Dio.
Di umorismo ma anche di creatività, di angoscia esistenziale, di persecuzione, di vocazione utopistica e messianica…: di tutto questo e molto altro parla il mirabile saggio di Luca De Angelis Il caso estremo dell’uomo – Essere scrittore ebreo (Ombre corte editore, pp. 367, 27,00 euro), un’opera monumentale e caleidoscopica che è uno scandaglio dell’interiorità ebraica nelle sue svariate forme ed esiti letterari. Un testo che è un prezioso scrigno di citazioni, un pozzo inesauribile di spunti e corto circuiti mentali, pagine che regalano sorpresa e arricchimento, un testo che andrebbe adottato in ogni liceo ebraico e statale, o facoltà di studi umanistici. Studioso di letterature comparate, musicista, saggista (ha pubblicato anche per Giuntina e Marietti), 57 anni, Luca De Angelis ha insegnato in svariate università (Trento, Trieste, Munster), vive a Ferrara e da anni si dedica all’approfondimento della condizione ebraica nei suoi vari aspetti letterari. È dalla figura di Romain Gary, scrittore ebreo lituano-francese, che De Angelis prende le mosse per farne la pietra angolare del suo saggio. «Ho sempre amato Romain Gary, un gigante, in Francia considerato un maitre-a-penser, un monumento: in un’intervista Gary citava il romanzo Ladri nella notte di Arthur Koestler, e parlava dell’ebreo come caso estremo dell’uomo. Rimasi folgorato. Ho voluto così disegnare un ritratto dello scrittore ebreo partendo da un omaggio a Romain Gary: così, nasce questo saggio, come un affresco dell’ebraismo letterario del XX secolo. Ho voluto scrivere un testo dal tono appassionato, che non rispecchiasse lo stile paludato e fumoso del mondo universitario per il quale la scrittura brillante è un peccato mortale, e dove più sei noioso, più sei autorevole». E prosegue: «Lo humour è sempre un genere di prima necessità del corredo psichico ebraico, per questo trova spazio in così tanti autori. Sa trasformare la sconfitta in vittoria, l’umiliazione in sorriso, sa insegnare a rispettare la debolezza e ad amarla. La cultura ebraica ha sempre tenuto in gran conto la debolezza umana, vulnerabilità che è la porta di accesso alla spiritualità. Il genio è sempre della debolezza e del suo rassicurante mormorio, dice Gary. E gli esseri umani sono umani solo perché hanno la capacità di trasformare in valore quello che li opprime, ricorda il regista di Shoah, Claude Lanzmann».
 Essere ebreo nel Novecento altro non è che essere il “caso estremo dell’uomo” e sono le sue peripezie identitarie e le vicissitudini di persecuzione e antisemitismo a dircelo, scrive De Angelis. L’esistenza ebraica non è forse stata estrema in ogni tempo e situazione, ancor più estrema nel XX secolo? La condizione ebraica è il paradigma di questo umano essenziale ed è per questo che ha potuto produrre tanta letteratura: un’angolatura dell’anima capace di trasferire e cogliere “l’intera vastità della vita” ci fa notare lo studioso in questo libro densissimo, che è un defilé della letteratura occidentale, un affondo in gran parte della storia letteraria del XX secolo. Sfilano storie, autori e personaggi indimenticabili, da Gregor Samsa a Micol Finzi Contini, da Zeno Cosini a Joseph K… Capolavori così numerosi che persino L’Altissimo, dai suoi sette cieli, “si sentirebbe sopraffatto da tutte quelle opere …”, scrive Andrea Jacchia nella sua bella prefazione. Da Heine a Kafka, da David Grossman a Primo Levi, da Malamud a Stefan Zweig, da Philip Roth a Italo Svevo, da Levinas a Amos Oz, da Imre Kertesz a Cynthia Ozick, da Elie Wiesel a Giorgio Bassani a Miro Silvera, solo per elencare una minima parte degli autori presenti nelle 367 pagine del volume.
Essere ebreo nel Novecento altro non è che essere il “caso estremo dell’uomo” e sono le sue peripezie identitarie e le vicissitudini di persecuzione e antisemitismo a dircelo, scrive De Angelis. L’esistenza ebraica non è forse stata estrema in ogni tempo e situazione, ancor più estrema nel XX secolo? La condizione ebraica è il paradigma di questo umano essenziale ed è per questo che ha potuto produrre tanta letteratura: un’angolatura dell’anima capace di trasferire e cogliere “l’intera vastità della vita” ci fa notare lo studioso in questo libro densissimo, che è un defilé della letteratura occidentale, un affondo in gran parte della storia letteraria del XX secolo. Sfilano storie, autori e personaggi indimenticabili, da Gregor Samsa a Micol Finzi Contini, da Zeno Cosini a Joseph K… Capolavori così numerosi che persino L’Altissimo, dai suoi sette cieli, “si sentirebbe sopraffatto da tutte quelle opere …”, scrive Andrea Jacchia nella sua bella prefazione. Da Heine a Kafka, da David Grossman a Primo Levi, da Malamud a Stefan Zweig, da Philip Roth a Italo Svevo, da Levinas a Amos Oz, da Imre Kertesz a Cynthia Ozick, da Elie Wiesel a Giorgio Bassani a Miro Silvera, solo per elencare una minima parte degli autori presenti nelle 367 pagine del volume.
FANTASIA, SIMBIOSI, ANGOSCIA
Una spiritualità ebraica ancestrale che si dischiude come un giacimento segreto, l’identità millenaria che si dispiega in temi universali, capaci di intercettare la modernità del proprio tempo. Fantasia e angoscia, immaginazione, persecuzione, simbiosi culturale, identità conflittuale: come dire l’incessante interrogarsi dell’artista sul proprio tempo e sull’essenza di essere uomo e ebreo nella Storia.
Perché il XX secolo ha prodotto un numero così strabiliante di capolavori e di scrittori? Il personaggio di Gregor Samsa, fa notare De Angelis, non poteva essere creato che dalla fantasia di un ebreo mitteleuropeo che da decenni sentiva accostare gli ebrei a parassiti e a scarafaggi. Gregor Samsa assurge così a emblema di una condizione umana universale e degradata, alienata da sé: ma tutto in lui è ebraico malgrado non compaia neppure una volta la parola “ebreo”.
“Quali sono le mie parole e i miei atti che mi autorizzano a considerarmi ebreo? E nei miei libri, che cosa segnala che io penso e scrivo all’ombra o alla luce dell’ebraismo?”, si chiedeva il poeta Edmond Jabés. L’idea è che si è ebrei anche malgrado se stessi; e che questa ebreitudine plasma tutte le molecole e i sussulti dell’atto creativo anche se non ne siamo consapevoli.
Letteratura quindi come forma dell’autocoscienza ebraica. Singolarità ebraica come riflesso di una condizione universale, “ebreo eternamente testimone, incarnazione luminosa ed eclatante della condizione umana”, come dice il pensatore francese Robert Misrahi.

De Angelis concentra parte della sua analisi sulle figure di Svevo, Kafka e Romain Gary.
Un lungo capitolo riassume in modo mirabile la storia dell’antisemitismo degli ultimi due secoli, e di come viene maturando la capacità visionaria dello scrittore ebreo, profeta malgrè lui.
De Angelis punta un dito accusatore contro una paludata critica letteraria che ha sempre voluto ignorare le stigmate ebraiche di tanti scrittori, guarda caso i più grandi e universali (Kafka, Svevo, Danilo Kis, Imre Kertesz, Romain Gary…). «Gli imbarazzi, i falsi pudori di molta critica che sotto un cumulo di ipocrisia chiude gli occhi di fronte alla complicata realtà dell’ebreo, appaiono ambigui, sono paradigmi indiziari di un larvato o sottile antisemitismo…, perché ignorarne l’ebraicità non consentirebbe altro che interpretare meglio la personalità letteraria di un autore, e attribuire importanza a ciò che è importante». Che si tratti dell’ebraismo ansioso di Kafka, dell’ebraismo pervasivo di Philip Roth o dell’ebraismo provvisorio di Andrè Aciman.
“EBREITUDINE”
Com’è possibile capire davvero La Metamorfosi di Kafka, scritta nel 1914, se non si coglie il costante clima di odio antisemita in cui l’ebreo Kafka era immerso? E tutto questo molto tempo prima di Hitler? Soltanto un ebreo che avesse introiettato la visione del nemico poteva concepire opere profetiche come La Metamorfosi, Il Processo, Il Castello, La colonia penale, storie nutrite di esperienza e sensibilità ebraica. Lo stesso dicasi per Italo Svevo ne La Coscienza di Zeno, Senilità…
De Angelis ricostruisce magistralmente la temperie culturale della prima metà del Novecento, le tappe salienti della preparazione culturale al nazismo, l’escalation filosofica che portò alla Shoah, da Schopenahuer a Wagner a Renan, da Drumont a Otto Weininger a Herbert Spencer, sottolineando il fatto che Hitler non elaborò mai una sola idea personale, visto che tutto era già lì, una “religione dell’odio” presente nel corpo sociale europeo da più di 50 anni, un antisemitismo parossistico e genocidario ben prima del Terzo Reich. È in questa dimensione apocalittica che vivono Kafka e Svevo, Karl Kraus e Franz Werfel, Stefan Zweig, Rosenzweig, Wittgenstein…: Praga e Trieste ferocemente antisemite quanto la Vienna di Karl Lueger, immerse in una psicosi collettiva che vede negli ebrei dei parassiti da eliminare pur di redimere il mondo, ripulirlo, renderlo migliore. “Le condizioni di Auschwitz erano già presenti nella vita di tutti giorni quando Svevo, Kraus e Kafka scrivevano”, dice De Angelis.
MARGINALI, PERIFERICI, DECENTRATI
Con la sua letteratura l’ebreo vuole parlare in nome dell’Uomo a tutti gli uomini, dalla propria condizione umana estrema. In questo risiede il tremendum della condizione ebraica. Rendere universale il proprio particolare, la propria esperienza. «Per quanto l’ebraismo possa aver dato l’impressione di essersi chiuso in se stesso, arroccandosi in un’etica particolaristica, è vero invece il contrario: da sempre ha promosso un’etica universalistica», vedi l’avversione per gli idoli che blocca l’universale nell’oggetto parziale, ne ferma il movimento e lo fa morire, scrive lo studioso. È Cynthia Ozick che a proposito di Malamud nota che “lo spirito ebraico è l’esatto contrario dell’etnicità e del provincialismo”. Il caso Heine è probante, ci spiega De Angelis: come è possibile che uno tra i più grandi poeti del romanticismo tedesco sia stato in grado con i suoi più intimi slanci di colpire al cuore la sensibilità tedesca? Non è forse perché, da ebreo, Heinrich Heine seppe cogliere la quintessenza dell’umano universale? Esattamente come Kafka, che più di chiunque ha saputo raccontare “l’universale senso di estraneità”, l’essere un deplacè, decentrato, desplaced person appunto, Kafka che nel contempo descrive la spinta così tipicamente ebraica di appartenere a qualcosa e di voler essere accettati dalla società “goy” che lo circonda? Dove sta allora l’ingrediente ebraico per eccellenza, si chiede lo studioso? Non sta forse in questa disposizione universalistica, in questa vocazione utopistica (Neher) e messianica? Perché non si è mai ebrei solo per se stessi ma per qualcosa che comporta delle responsabilità nei confronti del mondo e della Creazione.
Le personalità letterarie prese in esame fanno emergere curiose similitudini psicologiche. Ad esempio, la tendenza all’eccesso, la propensione all’iperbole, all’estremismo, un quid enfatico, una tonalità vitale da outsider: essere ebrei non vuol dire essere chiamati continuamente a superare se stessi e quindi a passare sempre la misura, scivolando spesso nella ricerca di un anticonformismo assoluto? Excedere hebraicum est.
IL BISOGNO DI “MASCHERARSI”
E poi il tema del déguisement, il bisogno di mascherarsi per essere se stessi, il mimetismo, il camaleontismo, scrittori che sono veri artisti della dissimulazione, dei mutanti letterari: per poter avere successo e sopravvivere, come ad esempio accadde a Romain Gary, il maestro di déguisement, di questo “darsi alla macchia” rispetto alle proprie origini ebraiche. Origini che scacciate dalla porta rientrano dalla finestra dell’anima. E ancora, questa prudente riluttanza a manifestare la judeité nella propria opera: perché, come diceva Leo Strauss, la correlazione tra scrittura e persecuzione esiste eccome, e se voglio essere letto e pubblicato forse è meglio che faccia finta di niente e che nasconda chi sono e da dove vengo.
 Nel saggio di De Angelis viene analizzata anche l’annosa polemica su Kafka-profeta-del-nazismo: «gli scrittori ebrei, specie quelli tra le due guerre, ascoltando gli avvertimenti del loro istinto e i movimenti magmatici e sotterranei della Storia, maturarono il senso di un pericolo incombente e seppero riversarlo poi nello spazio letterario in modo unico». Sismografi viventi dei movimenti tellurici della Storia, antenne predisposte a fiutare il pericolo: da qui questa chiaroveggenza letteraria, la spiccata tendenza profetica, questo percepire gli eventi prima che si producano per farne materia romanzesca.
Nel saggio di De Angelis viene analizzata anche l’annosa polemica su Kafka-profeta-del-nazismo: «gli scrittori ebrei, specie quelli tra le due guerre, ascoltando gli avvertimenti del loro istinto e i movimenti magmatici e sotterranei della Storia, maturarono il senso di un pericolo incombente e seppero riversarlo poi nello spazio letterario in modo unico». Sismografi viventi dei movimenti tellurici della Storia, antenne predisposte a fiutare il pericolo: da qui questa chiaroveggenza letteraria, la spiccata tendenza profetica, questo percepire gli eventi prima che si producano per farne materia romanzesca.
Essere scrittore ebreo quindi come paradigma dell’estraneità. Kafka e Gustav Mahler constatavano entrambi di sentirsi stranieri tre volte, boemi in Austria, austriaci tra i tedeschi e ebrei nel mondo: ovunque degli intrusi. È il pensatore Zygmunt Baumann con le sue importanti riflessioni sugli ebrei “stranieri universali” e quindi stranieri più radicali, che evidenzia il valore assoluto che l’unicità dell’esperienza ebraica ha acquisito. Non a caso, infatti, molti scrittori ebbero la coscienza di esercitare una funzione fertilizzante, di letame magnifico (Albert Cohen), di tessuto connettivo (Imre Toth), di mastice intellettuale (Feuchtwanger).
“AGENTS PROVOCATEURS”
Essere agents provocateurs, portatori di metissages creativi, soggetti culturali dall’identità composita. Senza contare che l’idea ebraica di gheulà, di redenzione universale ne fa soggetti in perenne caccia di un Paradiso perduto, in prima linea quando si tratta di utopie sociali. Chi, ad esempio, se non un ebreo come Zamenhof, poteva inventarsi l’utopia linguistica dell’Esperanto, l’idioma universale che avrebbe unificato i popoli?
A suo modo, la pratica letteraria rappresenta la via regia dell’autocoscienza ebraica, il luogo dove rintracciare in alta definizione l’anima della modernità ebraica. Non a caso, ci fa notare De Angelis, a moltissimi è capitato di ritrovare la propria ebraicità proprio con lo scrivere. “Non ho scritto queste pagine perché sono ebreo ma, al contrario, scrivendo questo libro sono diventato ebreo, ebreo per volontà e per riflessione», scriveva Pierre Vidal Naquet (Gli ebrei, la memoria e il presente). Anche Cynthia Ozick aveva dichiarato che al termine della stesura di Trust, un romanzo del 1966, si era accorta di averlo iniziato come scrittrice americana per poi ritrovarsi alla fine come narratrice ebrea. Perché nell’ora della scrittura, l’ebreo ritrova se stesso, raccontare ci permette di possedere il continuum dell’esperienza come non potremmo mai fare nella realtà.
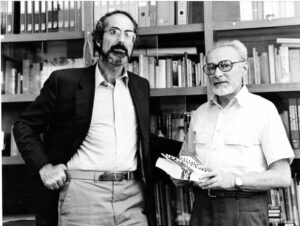 «Oggi sto lavorando a un saggio su Primo Levi e sulla letteratura della Shoah: Un grido vero – Riflessioni su Primo Levi, per Giuntina», conclude De Angelis. «Vorrei tentare di eliminare la retorica che ne circonda la figura. La mia chiave è la dimensione dell’urlo soffocato di Levi perché il grido vero è quello che non viene emesso, è il grido represso che ti muore in gola: la scrittura di Primo Levi è tutta uno sforzo per contenere la rabbia. Vorrei smontare l’immagine di un Primo Levi pacato, mite, sommesso: demistificare la figura di Levi scrittore vuol dire capire la rabbia che anima la sua scrittura».
«Oggi sto lavorando a un saggio su Primo Levi e sulla letteratura della Shoah: Un grido vero – Riflessioni su Primo Levi, per Giuntina», conclude De Angelis. «Vorrei tentare di eliminare la retorica che ne circonda la figura. La mia chiave è la dimensione dell’urlo soffocato di Levi perché il grido vero è quello che non viene emesso, è il grido represso che ti muore in gola: la scrittura di Primo Levi è tutta uno sforzo per contenere la rabbia. Vorrei smontare l’immagine di un Primo Levi pacato, mite, sommesso: demistificare la figura di Levi scrittore vuol dire capire la rabbia che anima la sua scrittura».



