di Nathan Greppi
Il volume, uscito nel 1967 in italiano e ristampato da poco, sostiene che c’è una distinzione tra la democrazia liberale, che garantisce ai cittadini la libertà di esprimere il proprio potenziale e scegliere che stile di vita condurre, e quella totalitaria, che attribuisce al potere costituito il compito di salvare l’umanità, un obiettivo al quale tutti sarebbero obbligati a puntare.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, numerosi pensatori si sono interrogati su come sia stato possibile che una società culturalmente avanzata come quella tedesca potesse sprofondare in una dittatura sanguinaria come quella nazista, spesso dando conclusioni e interpretazioni diametralmente opposte tra chi vi vedeva una matrice reazionaria e chi invece un frutto avvelenato della modernità.
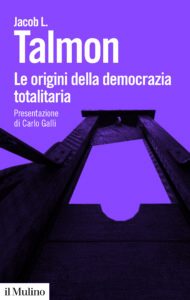 Uno degli intellettuali che si sono posti questo interrogativo è lo storico israeliano Jacob L. Talmon (1916 – 1980); nato in Polonia ed emigrato ai tempi del Mandato Britannico sulla Palestina, a suo tempo è stato per diversi anni docente di storia moderna presso l’Università Ebraica di Gerusalemme. Al tema del totalitarismo ha dedicato il suo saggio del 1952 Le origini della democrazia totalitaria, uscito in italiano per la prima volta nel 1967 e recentemente ripubblicato in una nuova edizione dalla casa editrice Il Mulino.
Uno degli intellettuali che si sono posti questo interrogativo è lo storico israeliano Jacob L. Talmon (1916 – 1980); nato in Polonia ed emigrato ai tempi del Mandato Britannico sulla Palestina, a suo tempo è stato per diversi anni docente di storia moderna presso l’Università Ebraica di Gerusalemme. Al tema del totalitarismo ha dedicato il suo saggio del 1952 Le origini della democrazia totalitaria, uscito in italiano per la prima volta nel 1967 e recentemente ripubblicato in una nuova edizione dalla casa editrice Il Mulino.
La tesi di fondo del libro, scritto nel pieno della Guerra Fredda, è che le dottrine politiche come il marxismo si basano su una fede messianica, che aspira a perseguire un bene assoluto e ad una moralizzazione della politica. Talmon, infatti, pone una distinzione tra la democrazia liberale, che garantisce ai cittadini la libertà di esprimere il proprio potenziale e scegliere che stile di vita condurre, e quella totalitaria, che attribuisce al potere costituito il compito di salvare l’umanità, un obiettivo al quale tutti sarebbero obbligati a puntare.
Il volume mette in luce anche una contraddizione di certi pensatori settecenteschi, e in particolare di quelli legati alla Rivoluzione francese: da un lato il desiderio di liberare il popolo dalle condizioni sociali che lo rendono svantaggiato, poiché gli uomini nascono puri e innocenti salvo essere corrotti dalla società che li circonda, ma dall’altro lato il desiderio di farlo “rieducare” da un’autorità illuminata. Da un lato il voler portare il popolo verso la strada della libertà, dall’altro lato volercelo guidare come un pastore guida un gregge di pecore.
Talmon attribuisce ai giacobini francesi l’origine della tendenza dei militanti politici di costringere il popolo non solo ad accettare la lotta perenne contro un nemico esterno o interno, ma anche a partecipare attivamente alla realizzazione dei loro obiettivi anziché limitarsi a restare degli spettatori passivi degli eventi. Da ciò deriva anche l’ambizione di mettere l’economia sotto il completo controllo della politica, che è alla base del marxismo.
Sebbene ai suoi tempi con il comunismo le dittature si fossero spostate da Occidente a Oriente, l’autore vede nel pensiero occidentale del ‘700 le origini dei totalitarismi del ‘900. Ossia, nelle tesi secondo cui la politica ha sostituito la religione nel tentativo di redimere l’umanità e di salvare il mondo. Un fenomeno che, secondo l’autore, accomuna sia le ideologie che perseguono la libertà che quelle che aspirano ad un potere assoluto che controlli ogni cosa.
Jacob L. Talmon, le origini della democrazia totalitaria, traduzione di Maria Luisa lzzo Agnetti, Il Mulino, pp. 480, 18,00 €.



