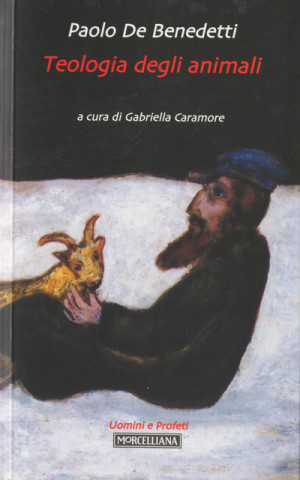di Vittorio Robiati Bendaud
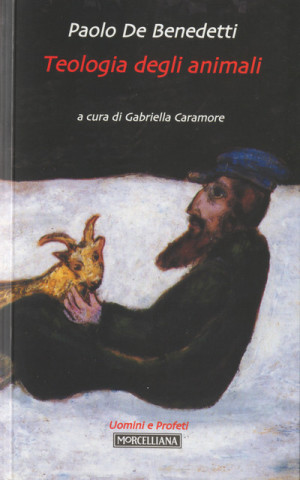
E così, caro Paolo, ti congedi da tutti noi nella prima fredda quindicina di dicembre, quando i giorni si fanno brevi e intorpiditi e le notti lente e sovrane, tra umide brume.
Talvolta mi chiedo che data di morte avremo mai in sorte; una delle due date che svetteranno sull’erba sopra di noi e che, come parentesi invalicabili, andranno a serrare l’inciso caduco della nostra esistenza. C’è chi nasce scaldato dal sole d’estate, con frutti maturi e pelli abbronzate; c’è chi reca in sé inciso il fascino nostalgico dell’autunno o l’eleganza stilizzata dell’inverno; vi sono i nati di primavera, sbocciati anch’essi con la stagione nuova. E poi la data di morte, inappellabile -almeno lei-. Cadrà in una giornata uggiosa e plumbea, in cui il freddo della morte si sentirà in sintonia con la rena scura e appesantita dal rigore invernale, sì che già il solo ritorno alle dimore confortevoli aiuterà impercettibilmente, ma realmente, i vivi a riprendere il loro cammino con minore disperazione? Oppure sarà un funerale d’agosto, con la terra polverosa e riarsa e un sole feroce a picco, che quasi non proietta più ombre; uno di quei funerali senza riparo dal sole, in cui il frigor mortis stona con un caldo mortale, in cui tutto sembra ancor più sospeso, ancor più inusitato e ammutolito?
Te ne vai, caro Paolo, sazio di giorni e un po’ stanco, dopo una lunghissima camminata, allontanandoti per altri campi e altre vie, avvolto nella nebbia, mentre ti scorgiamo per gli ultimi istanti. Solo pochi giorni e vi saranno gli scintillii di Chanukkhah e di Natale, quest’anno coincidenti. Uno dei Maestri del Dialogo ebraico-cristiano ci viene sottratto e i calendari ebraico e cristiano, anziché languire, ci dicono all’unisono di non disperare, che – coincidenza?- loro sono qui quest’anno proprio a testimoniare che non tutto è perduto, che molto alacre e innamorato lavoro non sarà dissipato, che –pur in mezzo alle tenebre che si fanno ognora più fitte- il seme è stato piantato e che, presto o tardi, darà i suoi frutti. Non temete, ci sussurrano i giorni festivi dai Calendari; non temete, ci sorride Paolo.
Solo Dio sa quanto mi mancherà quel sorriso pulito, per bene, franco e buono, che in sé raccoglieva e anticipava tutto Paolo De Benedetti. E quanto mi mancherà il suo roco “ciau”, con quella “u” finale, un po’ chiusa, da buon piemontese d’altri tempi! Che dire di quella grande mano paterna, ormai tremula, su cui cadeva, talora un po’ preoccupato, il mio occhio indiscreto? E della tua passione per il giudaico-piemontese e i suoi detti? Fùma parei -facciamo così-, che ne dici se adesso ne rievoco una io tra quelle che citavi spesso? E forse tu mi anticiperesti: Gnanca par chalòm! -“nemmeno per sogno”-, che ci vuole l’accento giusto e tu non hai orecchio. Ma, in verità, non avresti mai risposto così, perché la tua finezza e la tua cortesia erano straordinarie, come la tua discrezione.
Non voglio ora commemorare l’intellettuale acuto, la figura ponte tra ebraico e cristianesimo per biografia e per scelta, il piemontese elegante e affettuoso “in prestito” a Milano e a Urbino. Non voglio riflettere in questi giorni né del suo lascito originale né, ancor prima, della sua delicata e profonda unicità. Non voglio scrivere nemmeno dell’uomo ormai anziano che nelle decadi precedenti combatté assieme a Laras e a Martini una battaglia epica, che oggi, per vari motivi, forse ci appare lontana e sullo sfondo, ma che, ne sono convinto, tornerà negli anni di fondamentale e drammatica –sì, drammatica!- attualità.
Da poche settimane sono stato adottato da un gatto birbante e un po’ delinquente, che sto chiamando “Belva”. Caro Paolo, avrei voluto raccontarti di Belva e di tanto altro, ma non ne abbiamo avuto il tempo. Ora è, invece, il tempo del silenzio e del riposo. In tanti ti siamo grati. In tanti non dimenticheremo. In tanti ti abbiamo voluto bene.
E con un groppo alla gola ti dico Shalom, arrivederci!