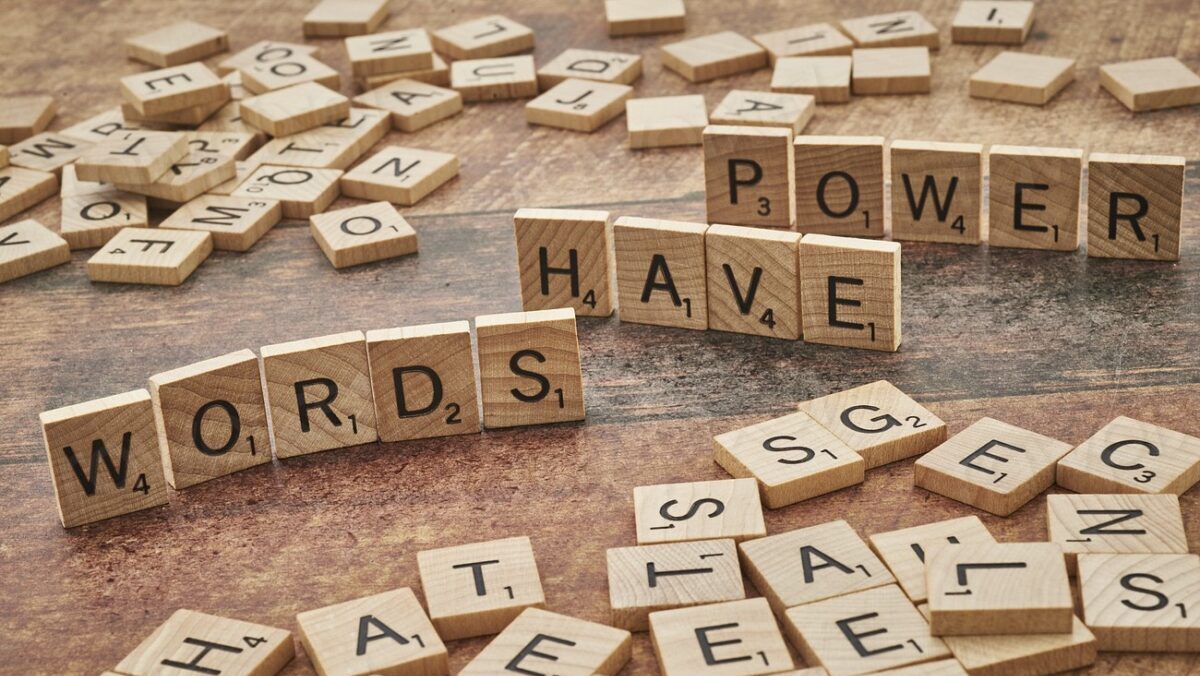di Claudio Vercelli
[Storia e controstorie] Da quando l’uomo si è manifestato come tale, ossia in quanto animale sociale, tale poiché in grado di interagire con i suoi simili, la lingua e il linguaggio comuni sono divenuti i vettori fondamentali della coesione sociale. Ovvero, l’intelaiatura dello stare insieme, nel corso del tempo e delle generazioni. Creando quindi comunità e società. Così recita l’enciclopedia Treccani su quest’ultimo passaggio: il linguaggio è “forma di condotta comunicativa atta a trasmettere informazioni e a stabilire un rapporto di interazione che utilizza simboli aventi identico valore per gli individui appartenenti a uno stesso ambiente socioculturale”. La storia stessa, per come la intendiamo, è intessuta di linguaggi e di comunicazioni, costruendosi sulla narrazione che si fa delle cose così come delle persone. Non a caso – se non ci si intende reciprocamente – i conflitti, a volte anche distruttivi, sono immediatamente dietro l’angolo. Basti pensare anche solo a una qualsiasi espressione di uso comune, del tipo: “mi hai capito o parlo cinese?”, che in sé rimanda alla necessità di comprendersi per coordinarsi vicendevolmente.
L’iperbole, in questo caso, serve infatti per rafforzare il concetto per cui qualsiasi intesa implica la comprensione del suo contenuto, il quale passa anche e soprattutto attraverso le parole pronunciate.
In un tale quadro, laddove la lingua è per eccellenza anche lo strumento che registra, consolida e amplifica un patto di condivisione – che ha molto a che fare con i ruoli sociali, l’eguaglianze, le diseguaglianze, le asimmetrie i differenziali di potere – si inserisce l’oramai annosa discussione del “politicamente corretto” e, quindi, dell’accettabilità, o meno, di parole, così come di espressioni, altrimenti d’uso comune ma fortemente caratterizzate sul piano della connotazione nei confronti di una qualche parte in gioco. Soprattutto laddove vi sia uno sfondo, a volte anche esplicitato, di offesa. In un tale contesto, il linguaggio triviale da caserma, machista e maschilista, sessuato poiché ossessivamente riferito agli organi genitali, non è solo offensivo in sé, ossia per i suoi maniacali rimandi a parti del corpo che altrimenti contrassegnano la privatezza di ognuno di noi, ma in quanto – ciò facendo – evidenzia una relazione di potere. Dove il “maschio” ribadisce la sua primazia sulla “femmina”.
Il ricorso alla genitalità come strumento di cristallizzazione di una diffusa subordinazione sociale, professionale, relazionale, economica, civile, addirittura istituzionale (le donne stanno “sotto”, i maschi “sopra”) è la riduzione del legame sociale, nella sua complessità, a vincolo etologico. Quindi, la compressione della vita collettiva a gerarchia di ruoli basata sull’istinto delle condotte animalesche. E non di certo perché il mondo animale abbia nel qual caso una qualche responsabilità ma, piuttosto, poiché la sua dipendenza dall’uomo è il segno, per l’appunto, della capacità di quest’ultimo di esercitare una più universale signoria, fondata sul potere di dominio che riesce a concentrare su sé stesso. Che nei sistemi patriarcali viene immediatamente esteso alle donne (anzi, all’”animale femmina”) dichiarandone una sorta di subordinazione tanto oggettiva quanto immodificabile. Una condizione gabellata per “naturale”, quindi inscritta in una presunta biologia quando, invece, nulla si dà come di più falso.
Tutto ciò, a conti fatti, costituisce senz’altro un punto di partenza per ragionare su convenzioni e convinzioni, galatei civili ma soprattutto diseguaglianze sociali. A patto, per l’appunto, che la questione non si riduca solo ad un conflitto nominalistico. Poiché nel qual caso, il vero oggetto non è la relazione asimmetrica di potere che le parole contrassegnano (e occultano sotto una nube purpurea di espressioni linguistiche sessuate) bensì l’ossessione formale per il ricorso alle parole medesime. Se così altrimenti fosse, si può allora stare certi che al cambiamento di circostanza – al medesimo tempo tartufesco, ipocrita e truffaldino – di un qualche linguaggio, non seguirebbe nessuna attenuazione concreta delle diseguaglianze.
Il vittorianesimo della lingua, ossia l’adozione di un filtro preventivo – basato quindi anche sull’autocensura – rispetto a tutte le manifestazioni espressive che possano rimandare, direttamente o indirettamente, a situazioni, relazioni, contesti di marcata asimmetria materiale di potere, non risolve da sé il problema dell’asimmetria medesima. Se non si ricollega ad una più generale azione politica per ricollocare risorse, opportunità e ruoli, può addirittura trasformarsi in una sorta di falsificazione, dove si finge una maggiore inclusione nel mentre, invece, le persone deprivate rimangono ai margini, se non definitivamente escluse, proprio in virtù di quello svantaggio di principio che gli deriva dall’appartenere a gruppi e identità subalterni così come allo svolgere ruoli subordinati. L’igiene della lingua nulla può se la mobilità sociale è bloccata.
E le nostre società sono drammaticamente caratterizzate da un ascensore che non porta le persone in alto, verso un orizzonte di possibilità, bensì verso il basso, quello che deriva dal crescente senso di impedimento, di impossibilità e di espropriazione. Magari pronunciandogli, nel mentre, tanto suadenti quanto infingarde parole di falsa rassicurazione. La parole, lo sappiamo, sono pietre; le pietre, tuttavia, sono assai più resistenti delle parole stesse. La storia lo dimostra chiaramente. Che ci piaccia o meno.