di Ilaria Ester Ramazzotti
Un fiore all’occhiello, un punto di riferimento, un’eccellenza nella ricerca storica. Questo è oggi il CDEC. Lo raccontano Gadi Luzzatto Voghera, Giorgio Sacerdoti, Liliana Picciotto, Michele Sarfatti. Ricordando il contributo fondamentale di Eloisa Ravenna. Tra Memoria e storiografia, 70 anni di impegno
L’idea iniziale sboccia con l’entusiasmo e l’impegno volontario di un gruppo di giovani ebrei, a pochi anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Oggi, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea è un istituto di ricerca storiografica e un punto di riferimento culturale per l’ebraismo italiano, con un ricco patrimonio biblio-archivistico e un osservatorio sul pregiudizio antiebraico.
“All’alba del nostro settantesimo compleanno, desideriamo rendervi partecipi del nostro percorso e invitarvi a celebrare con noi questo importante traguardo”, si legge sul sito internet del CDEC, che all’insegna del suo anniversario mette nell’agenda 2025 una serie di incontri, anche in vista delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, e immagina il suo prossimo futuro.
In diverse fasi storiche “la Fondazione CDEC, con i suoi protagonisti, ha precorso i tempi stimolando riflessioni e dibattiti intorno a temi contemporanei riguardanti gli ebrei all’interno della società italiana – prosegue in CEDC -. Allo stesso modo, in questo momento storico in cui vengono rimesse in discussione vecchie certezze e si avverte l’esigenza di nuove analisi del presente, vogliamo collocarci come centro che promuove non solo lo studio, la ricerca e la documentazione, ma anche il dialogo e il confronto delle idee”.
In queste pagine vogliamo ripercorrere il viaggio lungo settant’anni di quella chedal 1986 è la Fondazione CDEC, insieme ad alcuni dei suoi protagonisti: l’attuale presidente Giorgio Sacerdoti, il direttore Gadi Luzzatto Voghera, gli storici Michele Sarfatti e Liliana Picciotto.
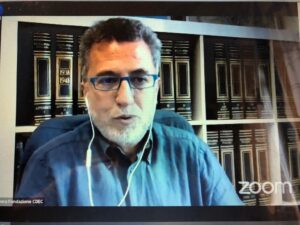
«Gli anniversari sono utili per fare bilanci delle attività svolte e per fissare sulle buone pratiche del passato le fondamenta delle attività del futuro – dice a Bet Magazine Mosaico Gadi Luzzatto Voghera-. Ripercorrere gli anni del CDEC dal 1955 ad oggi significa riflettere da un lato su un istituto di ricerca e di conservazionedocumentaristica, sulle sue dinamiche che lo hanno condotto da centro sostanzialmente volontaristico a diventare nel tempo un luogo di alte e diverse professionalità, con unaqualità sempre alta e rigorosa dei suoi prodotti culturali. D’altra parte si tratta anche di ragionare sulle mutazioni e trasformazioni avvenute in settant’anni nella società italiana in relazione alle attività proprie del CDEC stesso. È cresciuta la richiesta da parte di settori sempre più ampi di informazioni, di documentazione ancorata alla storia “come realmente avvenne”, come direbbe lo storico Leopold von Ranke. Ed è cresciuta al contempo la capacità del CDEC di professionalizzarsi e di offrire importanti servizi nel campo della divulgazione, della formazione, della metodologia storica (si parla da tempo di Public History, una pratica che il CDEC ha attivato si potrebbe dire in maniera naturale per decenni, prima che venisse codificata dalla storiografia). Il CDEC oggi, a settant’anni dalla sua istituzione, è un centro all’avanguardia nel campo delle Digital Humanities, conserva un patrimonio d’archivio in costante crescita, offre una biblioteca specialistica di assoluta rilevanza in sé e come luogo di aggregazione e cultura per una delle zone centrali di Milano, gestisce un fondamentale osservatorio che monitora le dinamiche dell’antisemitismo in Italia, attiva servizi di formazione e consulenza per le scuole e le università».
Sempre a proposito della qualità dei prodotti culturali, Michele Sarfatti riporta: «Negli anni in cui sono stato coordinatore delle attività e poi direttore ho tenuto molto ad alcuni progetti, ma soprattutto ho tenuto a che l’Istituto tutto mantenesse un forte livello di qualità nelle attività di ricerca e di documentazione. Questo peraltro era anche l’obiettivo dei due presidenti con i quali ho operato, e consentitemi di menzionare qui l’indimenticata Luisella Mortara Ottolenghi».
«Il CDEC ha fatto una lunga strada dai lontani inizi volontaristici della Federazione Giovanile Ebraica Italiana, settant’anni fa – racconta Giorgio Sacerdoti -. Tappe importanti sono state l’attività di ricerca diretta (la ricerca che sta alla base del Libro della Memoria a cura di Liliana Picciotto) e a sostegno di singoli ricercatori, che ha qualificato il CDEC come un istituto storico riconosciuto per la sua serietà nel panorama degli studi sulla Italia contemporanea; ma anche come un istituto di “battaglia”, impegnato nella ricerca della documentazione delle persecuzioni e della deportazione, inizialmente soprattutto nella assistenza alle indagini giudiziarie sui colpevoli condotte dalla magistratura in Germania e in Italia. Così, grazie alla sua serietà riconosciuta ora il CDEC è diventato un referente imprescindibile della Pubblica Amministrazione e a livello europeo e internazionale (pensiamo all’IHRA, l’International Holocaust Remembrance Alliance, e allo Yad Vashem) per le attività di lotta all’antisemitismo in Italia, nonché fonte di informazione per giornalisti e i media in genere». Uno sviluppo fatto dal susseguirsi di traguardi grazie all’impegno di guide dell’attività operativa come Eloisa Ravenna, Luisella Mortara, Michele Sarfatti, Gadi Luzzatto Voghera, Liliana Picciotto, ma altresì uno sviluppo di tipo istituzionale e finanziario.
Tappa fondamentale, la trasformazione del CDEC da Associazione a Fondazione nel 1986. Una tappa«operata quarant’anni fa, ma io già avevo avuto un ruolo nel procurare allora un lascito che ha consentito la capitalizzazione del CDEC necessaria alla trasformazione» ricorda Sacerdoti, che sottolinea anche l’importanza del «sostegno dell’Unione delle Comunità Ebraiche, che ha garantito il carattere ebraico del CDEC, espressione del mondo ebraico ma al contempo indipendente, dialogante e riconosciuto all’esterno come ente scientifico e obbiettivo». Non da meno, l’attuale presidente sottolinea «l’alto profilo dei membri del Consiglio, oltre che il sostegno nel mondo della politica e di quello della Comunità ebraica di Milano con la concessione della sede in via Eupili 8.Infine, l’impegno dei consiglieri nel ricercare finanziamenti, che sono essenziali non solo per consentire l’attività ma anche assicurare l’indipendenza economica, quindi anche politica del CDEC, attività culminata con l’allestimento della nuova sede di uffici e Biblioteca aperta al pubblico al Memoriale, con cui si è resa così possibile una stretta collaborazione. Èinvece carente, purtroppo – conclude Sacerdoti -, il sostegno economico della collettività ebraica italiana».
«Settanta anni sono un traguardo significativo – sottolinea Liliana Picciotto a Mosaico Bet Magazine -. Probabilmente i ragazzi che nel 1955 diedero avvio al Centro non immaginavano che il percorso del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea sarebbe stato così lungo e prestigioso. Questo anniversario è il risultato del lavoro di tutte le persone che, negli anni, hanno contribuito alla crescita del CDEC e alla realizzazione dei suoi numerosi e importanti progetti. È grazie al loro impegno che oggi il CDEC è un centro studi di rilevanza internazionale, riconosciuto in tutto il mondo, in dialogo con i principali istituti dedicati alla Shoah».
«In questi primi settant’anni molte persone si sono succedute al CDEC, lavorando alla raccolta della documentazione, alla ricostruzione della storia effettivamente accaduta, alla decifrazione del presente, al conseguimento delle risorse economiche – chiosa Michele Sarfatti -. Tanti hanno fatto, dato, costruito tanto, e il risultato è che il CDEC è stato e tuttora è davvero di tutti». Vediamo passo per passo le tappe di questa evoluzione, a partire dai suoi primordi.
Valigie piene di storia: la nascita del CDEC, custode di memoria viva
L’eco di un’idea risuona nel 1952 durante il congresso della Federazione Giovanile Ebraica d’Italia, a Genova: aprire un centro che raccolga evidenze della partecipazione ebraica alla Resistenza. Un’idea che si concretizza presto, nel 1955, decennale della Liberazione, con la fondazione del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) in un locale nel sestiere di Cannaregio a Venezia, col sostegno dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (oggi UCEI). Roberto Bassi, giovane consigliere della FGEI, ne assume la direzione e inizia a raccogliere testimonianze, pubblicazioni e documenti che custodisce in grosse valigie. Il ricordo si fa impegno vivo e le valigie si riempiono di storieindividuali e famigliari intrecciate con la grande storia.Il Centro cresce e si arricchisce anche grazie al lavoro del colonnello Massimo Adolfo Vitale, direttore del Comitato Ricerche Deportati Ebrei, fino a quando le preziose valigie non bastano più ela stanza di Cannaregio si fa stretta.IlCDEC si trasferisce allora in un ufficio della Comunità ebraica di Venezia, pronto ad accogliere nuove storie. Una nuova svolta porta al trasferimento a Milano, doveil Centro diventa un vero e proprio archivio, con la nomina a direttore dello storico Guido Valabrega,trovandocasa inspazidella Comunità ebraica.
I Quaderni che rompono il silenzio sulle persecuzioni antiebraiche durante il fascismo in Italia
Milano, anni Sessanta. Nei nuovi uffici milanesi il CDEC lancia la pubblicazione dei Quaderni, che tra il 1961 e il 1963 aprono il dibattito sulla persecuzione fascista degli ebrei in Italia. Tutto nasce nel ’61 con un convegno che ospita a Torino le voci di Carlo Leopoldo Ottino, Sandro Sarti, Guido Lodovico Luzzatto e dello stesso Guido Valabrega. “Gli interventi di ricostruzione storiografica di questo periodo sono da considerarsi espressione della forte esigenza da parte dell’ebraismo italiano (anche in conseguenza a una nuova ondata di antisemitismo e in corrispondenza a iniziative affini da parte dello Yad Vashem di Gerusalemme) di indagare e divulgare un’elaborazione della storia delle persecuzioni antiebraiche in Italia che non tacesse le responsabilità del fascismo – si legge sul sito web del CDEC -. I documenti raccolti durante il periodo Bassi ed elaborati durante il periodo Valabrega contenevano le prove che le autorità italiane erano state conniventi e collaborazioniste; quei documenti avevano così un ruolo fondamentale nell’aprire un dibattito sul carattere antisemita del fascismo, tema complesso che troverà spazio nel dibattito pubblico solo un ventennio più tardi”.Nel frattempo, la biblioteca si arricchisce e l’archivio cresce. Ma non solo. Il CDEC partecipa a mostre e produce documentari, tessendo legami con istituzioni internazionali. Il 1965 è l’anno di un nuovo trasloco: la sede si sposta in via Eupili 8, nello storico edificio della Comunità ebraica milanese.
La ricerca della giustizia contro i crimini nazisti e la nascita dell’Osservatorio Antisemitismo
1963: la direzione del CDEC cambia volto, ed è un volto femminile, quello Eloisa Ravenna, giovane originaria della Val di Susa, che nel 1966 promuove la pubblicazione dei Diari di Emanuele Artom. Ma la sua missione è portare i criminali nazisti davanti alla giustizia. Nel ‘64, la Procura Federale Tedesca la convoca a Dortmund affinché i documenti del CDEC diventino prove cruciali nei processi contro criminali di guerra nazisti. Anche i tribunali di Osnabrück e Berlino chiedono la collaborazione di Ravenna, che instancabilmente scava negli archivi di Prefetture e Questure, trovando documenti preziosi e rintracciando testimoni.
Nel 1971 collabora al caso di Friedrich Bosshammer, l’ufficiale della Gestapo responsabile delle deportazioni dall’Italia, che viene condannato all’ergastolo nel 1972. Per lei è una sudata vittoria, raggiunta un anno prima della sua prematura dipartita.
Ma facciamo un passo indietro, nel 1967, anno in cui irrompe la Guerra dei Sei Giorni in Medio Oriente: un’ondata di polemiche, soprattutto a sinistra, si scatena contro lo Stato di Israele. Germoglia allora in Eloisa l’idea di aprire una finestra di osservazione dei segnali di antisemitismo che emergono da intellettuali, circoli di leader politici e membri della società civile. Così un gruppo di donne si riunisce regolarmente, forbici alla mano, per sfogliare quotidiani e riviste alla ricerca delle tracce di un male antico: l’antisemitismo. Un lavoro certosino svolto da volontarie da cui nel ’75 sboccia l’archivioantisemitismoguidato da Adriana Goldstaub. Con lei, il CDEC pubblica due dossier fondamentali: uno nel 1974sull’antisemitismo dell’estrema destra italiana, l’altro nel 1982 sulle reazioni alla guerra del Libano. Tutte esperienze che porteranno all’istituzione dell’Osservatorio antisemitismo, oggi diretto da Betti Guetta, coadiuvata da Stefano Gatti.
I dati per laMemoria degli ebrei deportati nel lager nazisti
“Minuto, modesto, parco di parola, quasi sbiadito e incerto in mezzo alla gente: così appariva negli incontri fugaci. Ma era una forza che con volontà indomabile realizzava i suoi disegni; aveva una sicurezza interna che lo sosteneva senza tentennamenti, enorme coraggio e una dedizione agli altri che gli facevano affrontare le imprese più eroiche come semplici atti quotidiani”. Così la partigiana Lia Corinaldi, nel 1980sulla rivistaHaKehila,descrive il compianto compagno di lotta Raffaele Jona, presidente del CDEC dal1965.Scomparso nell’80, lascerà la presidenza a Luisella Ottolenghi Mortara, storica dell’arte che resterà in carica fino al 2004 e contribuirà a fare del CDEC un centro di ricerca strutturato e collegato alla rete scientifica internazionale.Già partigiano in Val di Lanzo e industriale a Ivrea,con Jona prende il via un’analisi scientifica dei dati raccolti sui deportati. A partire dall’elenco dei deportati ebrei del Colonello Massimo Adolfo Vitale del ’48, la ricercatrice Giuliana Donatiraccoglie nuovi dati per ricostruire le storie dietro ai nomi. Dal‘79 il lavoro è a cura di Liliana Picciotto, lavoro che culminerà nel 1991 con la pubblicazione deIl libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia 1943-1945. “Una pietra miliare per i discendenti e i conoscenti dei deportati e per il Paese intero che, grazie alla pubblicazione, può prendere coscienza del numero, dei nomi e delle dinamiche della deportazione ebraica”, scrive oggi il CDEC.
La voce e i volti dei sopravvissuti alla Shoah
Il lavoro di ricerca sulla deportazione non si ferma. Testimonianze audio e video vengono raccolte già fra gli anni Ottanta e Novanta, ma è dal 1992 che, anche in seguito al ripetersi di episodi neofascisti nelle piazze, molti sopravvissuti alla Shoah diventano meno restii parlare del loro vissuto. Nel 1995, a cinquant’anni dalla Liberazione, il CDEC inizia una serie di interviste video. Cruciale è la scelta di riportare i testimoni nei luoghi della persecuzione. La testimonianza di Liliana Segre permette ad esempio di ricostruire il funzionamento dei convogli dal Binario 21 della Stazione Centrale di Milano. Liliana Picciotto e Marcello Pezzetti raccolgono fra Milano, Roma e Venezia 105 interviste a ebrei italiani, alla base del film-documentario Memoria. I Sopravvissuti raccontano, diretto da Ruggero Gabbai e selezionato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino del 1997, in cui le telecamere viaggiano nei luoghi simbolo della Shoah, dalle carceri ad Auschwitz.
«La ricerca sui deportati e altre vittime della Shoah in Italia (con Il Libro della Memoria) è stato il progetto più importante che il CDEC ha sviluppato nel corso degli anni, seguito dal supporto al film Memoria con le testimonianze e la ricerca sui salvati, sempre a cura di Liliana Picciotto – riferisce Giorgio Sacerdoti -. Ora è in via di conclusione la ricerca sui Partigiani ebrei, di grande valore storico, una pagina inesplorata, ma anche di impatto mediatico-politico: gli ebrei non solo come vittime, ma come combattenti per la libertà contro il nazi-fascismo».
L’Archivio fotografico, album indelebile di vita ebraica
Al volgere del Millennio, l’attività delCDEC abbraccia tutta la realtà degli ebrei e della cultura ebraica in Italia. Michele Sarfatti, autore di studi scientifici sulla politica antiebraica del fascismo, diventa direttore nel 2002 e Giorgio Sacerdoti è presidente dal 2004. Nasce l’Archivio fotografico, che immortala migliaia di momenti di vita ebraica in Italia nel Novecento. L’idea è di Liliana Picciotto, che attraverso una campagna pubblica riceve numerosissimi scatti di vita quotidiana, di matrimoni e festività, di scene famigliari e sociali di diverse datazioni. Il grande lavoro di raccolta è realizzato daPaola Mortara e da una squadra di volontari; poi, nel 2010 ne diviene responsabile la storica della fotografia Daniela Scala. Nel 2015 il Bollettino della comunità ebraica di Milano dona il suo archivio editoriale di fotografie (Fondo Raul Elia) e il CDEC amplia i sistemi informatici necessari alla catalogazione digitale delle immagini. Oggi, l’Archivio fotografico conta un patrimonio di circa 50.000 documenti, che danno la testimonianza visiva della vita ebraica in Italia, per gran parte consultabile in forma digitale sulla fototeca della Digital Library.
Gli scampati alla Shoah e il portale sui Resistenti ebrei d’Italia
La ricerca sui deportati ebrei dall’Italia richiede 18 anni di lavoro e la registrazione di 700 interviste, raccolte nell’arco di otto anni. Da queste, nasce il libro Salvarsi. Gli ebrei d’Italia fuggiti dalla Shoah, a cura di Liliana Picciotto, edito nel 2017, con storie e testimonianze di ebrei salvatisi dalla Shoah in Italia, da soli o con l’aiuto e il soccorso di altri. Per la prima volta si risponde in modo scientifico alla domanda su come si salvano quegli ebrei presenti in Italia negli anni 1943-1945 e sfuggiti alle persecuzioni. Due anni dopo, inizia lo studio sistematico della partecipazione ebraica alla Resistenza italiana e nel 2022 viene pubblicato il sito internet Resistenti ebrei d’Italia.
“Nella mia carriera di storica ho affrontato, nei primi anni, il tema degli arresti e delle deportazioni: i responsabili, i dispostivi messi in atto per la persecuzione, le finalità immediate e gli obiettivi ultimi; in seconda istanza, ho trattato il tema della salvezza sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista dei meccanismi applicati dalla comunità perseguitata per resistere; in ultimo – scrive Liliana Picciotto – e, spero di chiudere così la trilogia, mi sto occupando in questi anni della partecipazione degli Ebrei alla Resistenza”.
“La ricerca si è concentrata sui nomi e le vicende dei cittadini ebrei che hanno contribuito al movimento di Resistenza anti-fascista e anti-nazista durante il biennio 1943-1945, riprendendo un antico progetto del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea fin dalle sue origini (1955) e mai del tutto abbandonato – scrive ancora Liliana Picciotto -. L’obiettivo è di mettere a disposizione degli studiosi una fonte preziosa per la storia del periodo 1943-1945, ma anche di illustrare il ruolo non secondario del gruppo ebraico, pur così minoritario, socialmente marginalizzato e poi perseguitato, nella ricostruzione dell’Italia democratica”.
La Memoria cresce: da piccola biblioteca a cuore della Fondazione al Memoriale della Shoah
Nel 1956 il CDEC catalogava 91 titoli tra libri e riviste. Ma era un seme ben piantato da cui germogliano 15.000 volumi nel 1997 e 24.000 nel 2009. “Oggi, la biblioteca conserva oltre 33.000 monografie, 800 tesi di laurea e una collezione di 700 manifesti relativi alle attività delle istituzioni ebraiche in Italia. La maggior parte delle opere risale al periodo successivo al 1920 e include pubblicazioni, opuscoli e miscellanee in italiano, francese, inglese, tedesco ed ebraico – scrive il CDEC -. Di particolare valore è il fondo di 300 libri in yiddish, unico in Italia, nonché le prime edizioni delle testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento e sterminio […] e la biblioteca più ricca di testi antisemiti pubblicati in Italia dal 1945 a oggi, un patrimonio fondamentale per lo studio di questo fenomeno nel contesto italiano”.
L’emeroteca custodisce 2.100 collezioni di riviste in diverse lingue, la più completa raccolta di periodici ebraici italiani e internazionali dal 1845 fino ai giorni nostri, oltre a riviste non ebraiche contenenti articoli e materiali sulle espressioni del pensiero, della cultura, dell’arte e della storia ebraica. Cuore della Fondazione,dal 2000 la Biblioteca fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale e nel 2022 si trasferisce insieme agli uffici del CDEC nella sede al Memoriale della Shoah in piazza Edmond Safra. Un nuovo inizio, con lo sguardo rivolto anuovi orizzonti di ricerca, documentazione e didattica, a cui si affianca una riorganizzazione dell’organico che prevedere Laura Brazzo, responsabile dell’Archivio storico e ideatrice della Digital Library, quale nuova vicedirettrice della Fondazione.
«Quando sono diventato direttore del CDEC nel 2016 – spiega Gadi Luzzatto Voghera – ho pensato che un centro come il nostro non potesse non avere una sua presenza importante nel campo dell’educazione. In effetti, il CDEC è sorto per iniziativa di giovani e proprio alle giovani generazioni deve indirizzarsi il suo lavoro nel tempo, seguendo e accompagnando i mutamenti dei linguaggi generazionali. Abbiamo avuto la fortuna e la capacità di legarci a un istituto statunitense, il TOLI – The Olga Lengyel Institute, con il quale portiamo avanti da anni un programma di formazione per insegnanti, reperendo le risorse anche in ambito europeo. Purtroppo il settore educazione (come quasi tutti i settori del CDEC) soffre di sotto finanziamenti e la sfida per reperire risorse è una costante del nostro lavoro. Ma sono certo che il CDEC si vada sempre più affermando come uno dei punti di riferimento nell’ambito della formazione sui grandi temi di nostro interesse, dalla Shoah alla Resistenza, dall’antisemitismo ai flussi migratori di ebrei dai paesi arabi nel secondo dopoguerra, tenendo sempre come centro di riferimento l’educazione all’integrazione e alla salvaguardia dei diritti umani. Lo facciamo anche in collaborazione con altri gruppi di lavoro altrettanto e forse più efficaci, si pensi a Yad Vashem, al Mémorial de la Shoah di Parigi, all’Associazione Figli della Shoah e altri ancora».
Prospettive e progettualità future della Fondazione CDEC
Valorizzazione, apertura di nuovi canali di ricerca, mutamento del vocabolario di riferimento esviluppo di metodologie didattiche innovative. Sono questi gli step del prossimo futuro della Fondazione, per Gadi Luzzatto Voghera. La valorizzazione riguarda forme innovative di utilizzo delle fonti: «Il patrimonio conservato dal CDEC è notevole, vanno identificate forme inedite per la comunicazione del suo contenuto, con l’obiettivo dichiarato di intercettare i linguaggi delle giovani generazioni – spiega l’attuale direttore -. Lo si fa già: ampia digitalizzazione del materiale, connessione a reti sovranazionali, realizzazione di mostre e installazioni innovative sono all’ordine del giorno. In tale contesto, il tema della comunicazione, rigorosa, corretta e adeguata alle nuove tecnologie, è essenziale».
Sull’apertura di nuovi canali di ricerca e raccolta di documentazione, c’è un’articolata progettualità, qui spiegata per punti da Luzzatto Voghera: «Primo: il progetto Edoth, inaugurato quasi vent’anni fa, è di grande importanza poiché lavora su un tema fondamentale e attuale, l’emigrazione, e su un tempo contemporaneo successivo alla Shoah. Secondo: l’esperienza ebraica in Italia; il CDEC è l’archivio del MEIS dalla sua fondazione, ma non basta:il MEIS non attiva ricerche mentre il patrimonio documentale conservato dal CDEC suscita continui e nuovi percorsi di ricerca. Il macro-tema del ruolo che la minoranza ebraica ha avuto in diversi settori nella costruzione di questo paese è da definire, ma di certo è uno dei percorsi da perseguire, in prospettiva peraltro allargata almeno all’Europa e al bacino del Mediterraneo. Terzo: la creazione di un archivio della musica ebraica. Quarto: un’implementazione delle esperienze di dialogo interreligioso e di confronto tra culture (su questo, per esempio, il Mémorial de la Shoah di Parigi ha da oltre dieci anni aperto gli acquisti della biblioteca a temi che vanno al di là della persecuzione degli ebrei). Tutto ciò richiede la formazione di nuove competenze – sottolinea -, al momento non sempre presenti».
Sull’importanza del mutamento del vocabolario di riferimento, lo sguardo è rivolto alla transizione dalla sola negatività evocata da certi termini, come per esempio l’associazione del termine “ebrei” a “vittime”, “persecuzione”, “antisemitismo”, “linguaggio d’odio” eccetera, a forme concettuali e linguistiche neutre o positive; seguendo lo stesso esempio, la parola “ebrei” si può associare a “resilienza”, “resistenza”, “cultura in varie forme”. Per quanto riguarda «lo sviluppo di metodologie didattiche innovative,con verifica della loro efficacia (di recente è per esempio stato prodotto un “libro-gioco” nell’ambito del progetto europeo Relation), il ruolo civile del CDEC ha un valore tanto in quanto riesce a creare con le sue attività nella società un effetto moltiplicatore in positivo, fatto di conoscenze storiche e di crescita di valori positivi”, conclude Gadi Luzzatto Voghera.
«Temo che anche nel futuro molti possibili finanziatori continueranno a prediligere il sostegno ai luoghi con ritorno di immagine rispetto ai luoghi ove si conserva, ci si forma, si forma – prosegue Michele Sarfatti -. Ma sinché ci sarà una minoranza ebraica in Italia, e anche quando inspiegabilmente dovesse non più esserci, resterà la necessità di un CDEC che documenti e approfondisca il come e il perché della vita positiva e delle tribolazioni di quella minoranza negli ultimi due secoli, con la dovuta attenzione alla Shoah».
«Vedo il futuro del CDEC come una sfida continua, con la necessità di adattarsi e rispondere a nuove situazioni ed esigenze – termina Giorgio Sacerdoti -: oggi più che mai la rinascita dell’antisemitismo collegato strumentalmente al ruolo di Israele come Stato del popolo ebraico».
«La Fondazione CDEC ha un compito fondamentale per il futuro: continuare a testimoniare, studiare e riflettere sulle dinamiche che hanno segnato la storia, ma anche sulle questioni attuali – evidenzia Liliana Picciotto -. Sebbene la Shoah sia sempre più lontana nel tempo, nuove preoccupazioni si affacciano alla nostra identità ebraica e occorre sempre studiare e riflettere sulla realtà che ci circonda. Le lezioni del passato non devono mai essere dimenticate”.
Alla fine di questo nostro excursus nel tempo, in cui ci piace pensare che il passato abbia sempre la forza di parlare la futuro, vogliamo riportare la voce di Liliana Picciotto raccolta al Primo Forum Nazionale delle Donne Ebree di Italia tenutosi a Milano a Palazzo Marino nel ’22: «Prendo in prestito le parole di un grande intellettuale, giovane musicista e compositore che a Bologna tra il 1943 e il 1945 si adoperò per fabbricare centinaia di documenti falsi agli ebrei minacciati di morte, mettendosi continuamente in pericolo e finendo scoperto e arrestato. Finì la sua vita ad Auschwitz. Il suo nome, Mario Finzi, non è molto noto, l’abbiamo da poco riscoperto al CDEC conducendo una ricerca sulla partecipazione degli ebrei alla resistenza. Ecco che cosa dice, e ce lo dice al di là del tempo, qualcosa valido per noi oggi e per il futuro: “Ognuno di noi ha l’illusione di vivere di una sola vita, della propria vita, ma in realtà vive tante vite quante sono le persone con le quali viene in rapporto. E ogni nostro rapporto che non sia superficiale lascia qualcosa di sé nello spirito dell’altro e fa sì che la vita di questo diventa vita nostra”».



